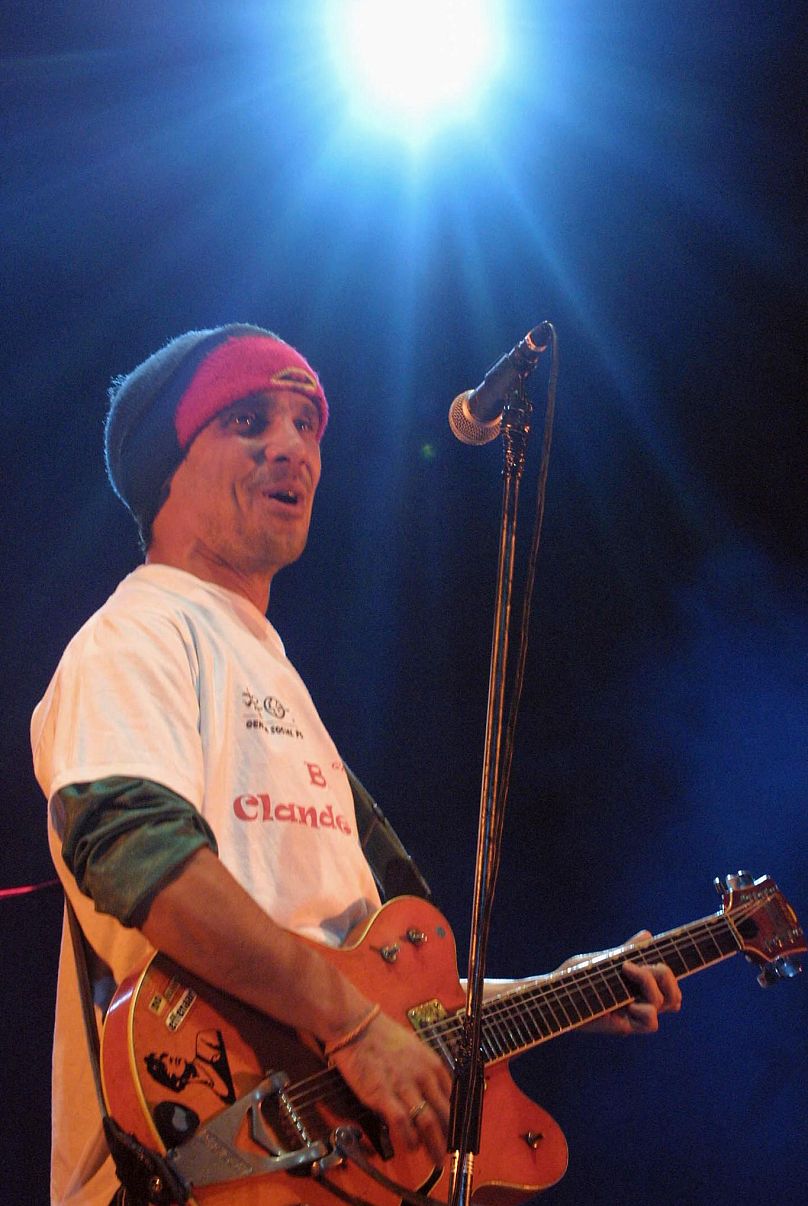Le strade di Genova avrebbero dovuto tenere a battesimo il primo ritrovo di massa del più grande movimento globale mai visto, ma furono testimoni di una maratona di violenze
Sono passati 20 anni da quel 19 luglio del 2001, quando una marea umana di 200mila manifestanti si riversò per le strade di Genova, che avrebbero dovuto tenere a battesimo il più grande movimento di protesta mai emerso nella storia, ma finirono invece per diventare testimoni di una maratona di violenze quasi ininterrotta, trasmessa in presa diretta dagli schermi televisivi di tutto il pianeta.
Due decenni, e la ferita aperta dal G8 di Genova ancora continua a sanguinare nella coscienza della Repubblica.
Per molti dei manifestanti che si trovarono scaraventati in quella bolgia di cariche e manganellate, quei tre giorni rappresentano la definitiva perdita dell'innocenza: da tutto il mondo si erano messi in viaggio per prender parte a quel movimento che nei mesi precedenti aveva assunto dimensioni inaudite.
A Genova erano arrivate delegazioni sindacali, organizzazioni umanitarie attive nel sud del mondo, movimenti pacifisti ed ecologisti, gruppi antagonisti, associazioni cattoliche e religiose.
Ad accoglierli trovarono una città blindata - suddivisa in zone di sicurezza in cui l'accesso risultava difficoltoso perfino ai residenti - dove da settimane serpeggiava il terrore della guerriglia urbana.
Le informative della Questura paventavano lanci di frutta "con all'interno lamette di rasoio" o di palloncini "pieni di sangue umano, raccolto con la complicità di medici e infermieri", oltre a infiltrazioni capillari dell'estrema destra tra i dimostranti.
All'aeroporto Cristoforo Colombo vennero installate batterie di missili terra-aria, per il timore di attacchi contro i leader riuniti a Palazzo Ducale. Nei giorni precedenti al meeting, inoltre, gli allarmi bomba si erano andati moltiplicando, finché un pacco esplosivo ferì davvero un agente di polizia in una caserma.
Un inizio tranquillo
Ma, arrivati a quel fatidico 19 luglio, le forze di sicurezza assicurarono che tutto sarebbe filato liscio. Come Marco Imarisio ha ricordato sul Corriere della Sera, il colonnello dei carabinieri Giorgio Tesser convocò gli organi di stampa, sostenendo che - al netto dei Black block che avrebbero potuto creare qualche disordine - ci fosse un accordo "quasi scritto" con gli organizzatori del corteo.
E quella prima giornata di manifestazioni, in effetti, trascorse senza scossoni: cinquantamila persone sfilarono per rivendicare i diritti di migranti ed extracomunitari, e i primi, timidi accenni di disordini da parte del blocco nero furono smorzati sul nascere dagli stessi manifestanti.
20 Luglio
È il 20 luglio che segna l'inizio del disastro. Fin dalla mattina, i manifestanti del blocco nero si palesano con una presenza massiccia, seppur assolutamente minoritaria rispetto alla marea umana dei cortei autorizzati, dai quali vengono in diverse occasioni espulsi per mano degli stessi manifestanti.
In pieno centro cittadino sfilano con piglio marziale, al rullo di tamburi che intonano una marcia di guerra, prima di iniziare a devastare vetrine e incendiare automobili.
Ma le forze dell'ordine non intervengono.
La carica travolgerà invece il corteo delle "Tute bianche", all'altezza di via Tolemaide, dove i manifestanti vengono attaccati da circa 300 carabinieri appoggiati da una colonna di camionette e blindati. La ricostruzione processuale parlerà in seguito di un errore di percorso: la colonna era diretta verso il quartiere di Marassi, dove stavano convergendo anche gli appartenenti al blocco nero.
È a questo punto che il G8 di Genova degenera in quella che Amnesty international avrebbe in seguito descritto come "la più grave sospensione dei diritti democratici a partire dal dopoguerra".
Durante la fuga, parecchi manifestanti confluiscono in piazza Alimonda, a 90 metri da via Tolemaide, dove finiscono però bersagliati da un nuovo lancio di lacrimogeni e schiacciati tra diversi gruppi di agenti.
È qui che perde la vita Carlo Giuliani, ucciso da un colpo sparato dalla pistola di Mario Placanica, carabiniere di leva che si trovava all'interno di un defender rimasto bloccato durante la ritirata e subito assaltato dai dimostranti.
21 Luglio
Una dinamica simile si ripete anche il giorno seguente. Un folto gruppo di manifestanti del "blocco nero" infiltra il corteo autorizzato, dando avvio a numerosi episodi di vandalismo e distruzione. Saranno gli stessi manifestanti a cercare, senza successo, di neutralizzarli, dopo aver chiesto ripetutamente l'intervento delle forze di sicurezza.
Anche stavolta, il tardivo intervento della polizia colpirà in modo indiscriminato l'intero corteo.
Ma se i guastatori in nero riescono agilmente a fuggire, il resto dei manifestanti se la vedrà perfino più brutta del giorno prima: mentre Genova è ormai trasformata in un campo di battaglia, manifestanti fermi e con le mani alzate - inclusi anziani e giovani donne - vengono manganellati senza tregua. Chiunque, tra i feriti, riesca ancora a stare in piedi, viene inoltre strappato di peso ai paramedici e messo in arresto.
L'assalto alla Diaz
Ma il peggio deve ancora arrivare. Nella serata del 21 luglio, in una riunione partecipata da alti vertici di polizia, viene ordinata l'irruzione alla scuola Diaz, dove ancora dormivano un centinaio di manifestanti.
Secondo la successiva ricostruzione delle forze di sicurezza, che presenta però diverse discrepanze, l'operazione sarebbe stata ordinata in seguito alla sassaiola di cui nel pomeriggio era stata fatta oggetto una volante di fronte all'edificio. Al processo per i fatti di quella notte, il dirigente Ansoino Andreassi avrebbe poi parlato della necessità "di fare molti arresti, per recuperare l'immagine delle forze dell'ordine".
L'operazione degenera in quella che sei anni dopo, in una dichiarazione resa gli inquirenti, verrà definita dal vicequestore aggiunto Michelangelo Fournier come "una macelleria messicana".
Dopo lo sfondamento del cancello esterno e del portone d'ingresso, i manifestanti - perlopiù stranieri, trovati ancora una volta, in massima parte, immobili e con le mani alzate - vengono manganellati selvaggiamente e senza tregua. Anche l'adiacente scuola Pascoli - dove dormono 93 giornalisti, quasi tutti accreditati - viene assaltata.
Su un centinaio di occupanti, i feriti saranno più di ottanta: uno di loro verrà portato fuori dall'edificio già in coma, riportando in seguito problemi permanenti; mentre il giornalista inglese Mark Covell se la "caverà" con otto costole rotte, un polmone perforato, un trauma cranico e cinque denti persi.
L'intera catena di comando dell'operazione sarà in seguito condannata per falso, dopo un processo andato avanti per una decade: tra le prove raccolte in loco che furono presentate per motivare quella carneficina - perlopiù attrezzi da lavoro rinvenuti nei ripostigli della manutenzione - fu infatti inserita anche una bottiglia molotov che era stata trovata in precedenza, in un'altra zona della città.
Ma per le violenze avvenute quella notte - e nei giorni successivi nella caserma di Bolzaneto, dove gli arrestati della Diaz e dei giorni precedenti furono sottoposti a sevizie continue, gratuite e arbitrarie - saranno in pochi a pagare, dal momento che fino al 2017 il reato di tortura è rimasto assente dal codice penale italiano.
Proprio in quell'anno, rispondendo al ricorso delle vittime, la Corte europea dei Diritti umani condannerà l’Italia per non aver svolto un’indagine efficace sulle azioni degli agenti durante il G8 del 2001 a Genova: secondo la sentenza, Diaz e Bolzaneto rappresentarono un buco nero del diritto, dove le garanzie più elementari furono sospese.